| Categoria bittorrent | Ebooks |
|
|
| Descrizione |
ALBERTO MORAVIA
L'UOMO CHE GUARDA


Autore: Alberto Moravia
Titolo: L'uomo che guarda
Anno: 1985
Lingua:Italiano
Genere: Romanzo
Dimensione Pack: 3,76 Mb
Formati del file df(A5),Doc,Doc(A5),Epub,Mobi,Lit df(A5),Doc,Doc(A5),Epub,Mobi,Lit
Caratteristiche : Scansione scala di grigi 300 dpi - Indici interattivi

“È una bellezza, quella di mio padre, almeno per me, collegata in un qualche modo con la sua importanza professionale. La bellezza di un barone universitario, di un uomo di scienza noto e consacrato; insomma una bellezza irrimediabilmente accademica. Perché dico: irrimediabilmente? Perché il mio rapporto con lui ha risentito di questo suo carattere in maniera persistente e, appunto, irrimediabile. Fin da bambino, tutte le volte che mi accostavo a lui con affetto sentivo ad un certo momento la dignità professionale frapporsi tra noi, simile a un vetro trasparente ma infrangibile, che mi permetteva magari di ammirarlo ma non di amarlo. Nell’infanzia non riuscivo a identificare il motivo di questa impossibilità di comunicazione affettiva; così finivo per attribuirne la causa alla mia timidezza. Più tardi, negli anni dell’adolescenza, ne ho dato la colpa all’incapacità di mio padre di uscire dal suo personaggio sociale; e allora, per gradi, sono arrivato a provare per lui quasi dell’avversione. Ma non sono mai stato completamente sicuro che in fondo la colpa non fosse invece mia, almeno in parte. Ma perché? In che cosa avevo sbagliato nei suoi riguardi? Me lo domando ogni mattina mentre l’osservo che mangia e non riesco a darmi una risposta”.
Edoardo detto “Dodo” è un professore di letteratura francese che vive con la moglie Silvia nella casa paterna, in due stanze ricavate in fondo ad un lungo corridoio. Nel ’68, in piena contestazione, aveva rinunciato all’appartamento borghese ereditato dalla madre per lasciarlo alla figura paterna, professore di fisica, ricco e stimato, ora in pensione.
Un incidente automobilistico costringe quest’ultimo all’infermità in casa, chiuso in una camera da letto, in un andirivieni di fisioterapisti, infermiere ed ex allieve dall’età disparata.
Dodo ha un rapporto conflittuale con il padre, un odio/amore risalente ad epoche lontane, quando la madre, ancora viva, era isolata dalla vita coniugale con un senso di frustrazione per un marito che l’aveva sposata per denaro.
La madre approfittava di ogni momento, con ogni piccolo sotterfugio, per avvicinarsi a lui, avvantaggiandosi anche delle occasioni offerte dal piccolo Dodo. In una di queste, il bambino Dodo si trova ad assistere, fuori dalla porta della camera paterna, ad una scena di sesso dalle forti sfumature animalesche che lo dominerà inconsciamente tutta la vita: il padre trasfigurato e la madre sottomessa, ripiegata su una scrivania che gli appare come se avesse la testa mozzata. Forte è il senso del dolore per una scena che allora non poteva capire mentre emerge l’odio per la figura paterna vista, per la prima volta, in tutta la sua potenza. Dopo quel momento, il bambino dà uno schiaffo al padre.
Dodo si sposa e, con la moglie Silvia, ha rapporti quotidiani ma in pieno silenzio, cristallizzati in un’unica posizione contemplativa che gli permette di sovrapporre l’immagine della donna con quella di una Madonna che visitava da bambino in chiesa: il simbolo della purezza e della placidità spirituale aveva sostituito, nel tempo, quella scena di crudezza coniugale come suo tormento esteriorizzato.
“Mi soffermo sul carattere di scoperta della scopofilia: lo scopofilo spia non soltanto ciò che è proibito ma anche ciò che è sconosciuto; in altri termini, la scopofilia ha bisogno di scoprire l’ignoto. Allora, tutto a un tratto, mi accorgo che c’è un rapporto oscuro ma indubitabile tra il modo di scoprire della scopofilia e quello della scienza. Lo scienziato, infatti, che riesce a spiare un segreto della natura per la strettissima fessura di un ardimentoso esperimento, alla fine, quando tutto è stato detto, deve provare gli stessi sentimenti di ardente curiosità e di sfida profanatoria del ragazzo inesperto che, nella poesia di Mallarmé, spia, per la fessura della porta, l’apparizione incredibile della conchiglia pallida e rosa” .
Il contrasto con il padre domina ogni momento della sua esistenza fino a coinvolgere aspetti diversi che nel romanzo vengono svelati con l’uso delle metafore.
Il sesso è, per l’appunto, l’esternazione di questo rapporto conflittuale che converge in atteggiamenti di puro voyeurismo perché provocati dall’atteggiamento paterno. Continue prove di potere, tra l’uno e l’altro, che si manifestano nella dimostrazione di virilità paterna su quella filiale. Prove che finiscono per intrappolare la stessa Silvia in un rapporto sottilmente perverso che, poco alla volta, apre le sue porte a Dodo.
Si osserva, a nostra volta in pieno voyeurismo, il triangolo amoroso tra personaggi che snaturano il legame che li accomuna: figlio-moglie-padre.
Dodo, il figlio, è il voyeur che si trascina tra letteratura e vita in continue citazioni di se stesso bambino. È la curiosità fatale di trovare i francobolli promessi che gli fa accostare il viso alla porta durante il rapporto sessuale dei genitori; è la sfida contro se stesso che lo porta ad osservare Fausta, l’infermiera, seduta in una poltrona, nuda dalla vita in giù che si fa guardare dall’infermo, ripetendo posizioni fotografiche che l’avevano vista protagonista tempo prima (qui il voyeurismo è duplice con un accenno alla fotografia, strumento per lui essenziale); è un gioco sottile che lo spinge ad immaginare Pascasie, la donna di colore, che seduce una bambina così come in una poesia giovanile di Mallarmé; è il gusto del proibito e dell’ignoto che lo porta, di notte, a curiosare tra i libri della biblioteca paterna alla ricerca di notizie sulla fissione nucleare, un accesso alla sua realtà che fa da contrapposizione alla letteratura rappresentata dalla collezione di Proust, intonsa, ingiallita dal tempo e dalla polvere, sulla quale si solleva lo sguardo compiaciuto di Dodo. Il suo trionfo è là, la conoscenza di qualcosa che al padre sfugge; è la visione contemplativa della vita che si ripercuote nei rapporti intimi con la moglie Silvia.
Il padre è l’esibizionista, l’antagonista di cui non si può fare a meno. Spesso sa di essere osservato; spesso si pone, senza falsi pudori, in posizioni imbarazzanti davanti a Dodo per compiacenza di sé e del suo potere. È il sesso lo strumento di potere; è il membro paterno, quasi innaturale, quasi autonomo perché ancora giovanile e prestante rispetto al corpo avvizzito, il mezzo simbolico di rappresentazione eccentrica di una realtà dai contorni estesi: la contrapposizione della borghesia sul popolo, della ricchezza sull’indigenza, degli scienziati sugli intellettuali. La vittoria del padre, con tutto ciò che esso rappresenta, viene di fatto rivelata con l’accettazione, da parte di Dodo, dell’appartamento che aveva rifiutato in perfetto stile sessantottino. È Silvia il motivo di questa umiliazione: per non perdere la moglie, l’intellettuale rinuncia alla lotta.
Silvia è una delle tante figure femminili dei romanzi moraviani, trattate come “cose” perché in esse non s’intravede quel vigore che le fa emergere dalla gabbia in cui si auto-rinchiudono. In questo romanzo è, per l’appunto, la “cosa” che permette a padre e figlio di comunicare; attraverso il suo ventre si mescolano le due identità in continua lotta.
Non più donna florida a cui converge l’istinto maschile, ma magra, dall’ovale “allungato, con occhi grigi e fissi da miope, naso lungo e stretto, bocca piccola dall’espressione mesta e mortificata”, così la descrive Moravia accentuando l’aspetto villoso e quasi animalesco del pube (così come in Fausta), Silvia non conosce riscatto di se stessa, non ha ideali e non sa vivere per essi. Si pone ambiguamente in appoggio all’uno o all’altro, a seconda delle occasioni, muovendosi in un ambiente che non le dà alcuna luce interiore. Del resto, lei stessa non sa cosa volere: l’appartamento ed il padre o la scomodità delle due camere ed il figlio, il pietismo contemplativo o la furia selvaggia del dominio sessuale. Non ha morale, non traspare un reale senso di colpa se non per l’infedeltà, quantomeno per il soggetto che ne è protagonista assieme a lei.
Dodo scopre tutto, prima con la logica della memoria e poi con prove testimoniali che rifiuta di accettare, se non dentro se stesso.
In quel momento il tradimento è doppio, il sapere che Silvia ha un altro uomo che la fa sentire libera gli fa male, che, sin dall’inizio del matrimonio, sia il padre è un dolore più intenso perché la sconfitta è ancor più grande: la casa, gli ideali ed ora anche la moglie. Lo schiaffo che diede da bambino ora si tramuta nella volontà dell’omicidio perché solo così può vendicare l’umiliazione provata, ma è Pascasie, come se fosse la sua coscienza (è anche lei, a suo modo, la donna a metà, una voyeur), che lo dissuade convincendolo che non si tratta di un rapporto paritario da uomo a uomo, ma che l’altro è il padre, figura da rispettare sempre, in ogni occasione, perché è lui che incarna la saggezza del mondo.
“Ma a questo punto mi colpisce l’analogia tra la parola fissione e la parola fessura. L’operazione scientifica che porta alla scoperta dell’energia atomica, implica una iniziale fenditura, parola che può essere applicata così all’atomo come al sesso femminile. In ambedue i casi avviene la scoperta (nel senso letterale di scoprire un oggetto finora coperto) di un solenne mistero della natura. Il mistero che ha avvolto da tempo immemorabile così la composizione della materia come le origini della vita. Ma una simile analogia tra due scoperte così diverse sia negli intenti sia negli effetti, non rischia di essere arbitraria e ingiusta? Non c’è insomma una differenza sostanziale tra la curiosità del voyeur e quella dello scienziato? Muovo a me stesso quest’obiezione e la trovo fondata ” .
Dalla visione dell’incubo nucleare, particolarmente intenso in quegli anni, nasce questo romanzo a cui seguirà “L’Inverno nucleare”.
Il sesso è uno degli elementi centrali della sua narrativa, anche se nel tempo ha perso la forza della novità, della magia e del mistero riuscendo, tuttavia, ad essere ancora strumento di comunicazione.
Del resto non possiamo pensare che il Moravia di “Agostino” sia rimasto identico a se stesso in tutti gli anni trascorsi. Lo scrittore ha quasi 80 anni quando scrive “L’uomo che guarda” e, forse, osservando con maggiore attenzione, vediamo l’immagine speculare tra padre e figlio e lo stesso Moravia.
Egli è il figlio, ma è anche il padre: il potere del successo acquisito negli anni a confronto con lo spirito contestatore sfumato dal tempo.
FONTE :http://www.lankelot.eu/


Alberto Moravia
Alberto Moravia è nato a Roma il 28 novembre del 1907 da Carlo Pincherle architetto e pittore e da madre anconetana della famiglia De Marsanich. Fino all’età di 9 anni "la vita del piccolo Alberto si dipana in una duplice direzione: nella reale consistenza del mondo borghese in cui è nato, tra le cure affettuose delle sorelle Adriana ed Elena; e in quello ben più vero, ma crudo e disarmante, d'una Roma suburbana, con le sue miserie e le sue costrizioni esistenziali" (Pandini).
A circa dieci anni, Moravia si ammalò di tubercolosi ossea secca e per questa ragione dovette interrompere gli studi ginnasiali e, costretto a stare a letto, si diede alle letture degli autori preferiti: Dostoevskji, Goldoni, Shakespeare, Baudelaire, Leopardi, Manzoni, il teatro classico, Eliot, Apollinaire. In questo clima nasce la sua vocazione di scrittore precoce. Dal 1923 al 1924 la malattia raggiunse punte assai gravi, ma le cure indovinate e precise del sanatorio lo portarono alla guarigione e nel 1925 poté trascorrere a Bressanone un periodo di convalescenza.
Moravia intraprese a scrivere Gli indifferenti sin dal 1925, ma lo pubblicò nel 1929 a proprie spese, in quanto l’editore Alpes di Milano pretese cinquemila lire per la pubblicazione del suo romanzo.
Il romanzo per il suo successo critico e per il suo spirito polemico-realistico mise in contrasto Moravia col regime fascista, tanto che preferì evadere dal clima oppressivo del regime recandosi a Londra nel 1931 e poi a Parigi. Quindi a New York nel 1934, chiamato da Prezzolini alla Columbia University, dove tenne conferenze su Manzoni, Verga, Fogazzaro, D'Annunzio. Nel 1935 ritorna in Italia e intanto finisce la guerra etiopica e Mussolini si avvicina alla Germania, dando luogo a una politica imperialistica culminante nell'Asse Roma-Berlino.
Ricominciò di nuovo i viaggi, e gli anni tra il 1933 e il 1943 furono i peggiori della sua esistenza dal punto di vista della vita pubblica, per le persecuzioni naziste contro gli ebrei. Egli stesso dichiarava:
Forse per questo facevo tanti viaggi, per sottrarmi ad un'atmosfera avvelenata dalla menzogna, dalla paura e dal conformismo.
Avvenimenti importanti in questo periodo furono il matrimonio con Elsa Morante (1940) e, subito dopo un periodo di fuga e latitanza, in seguito al quale riuscì ad arrivare con la moglie a Fondi, dove trovò ospitalità presso la famiglia di un conoscente, il giudice Mosillo, che lo fece alloggiare in un cascinale; nel La Ciociara rivivranno molte delle esperienze di questo periodo. Nel 1945 fu premiato per il romanzo Agostino, scritto nel 1943. La fine della guerra dette la possibilità all’autore di riprendere la sua attività con la pubblicazione de La romana (1947), La disubbidienza (194 e Il conformista (1951). e Il conformista (1951).
Nel 1952 gli viene assegnato il premio Strega e i suoi libri, mentre da un lato venivano messi all’indice, erano tradotti in quasi tutte le lingue e alcuni utilizzati come argomenti di grandi films di successo in chiave neorealistica: La romana con la regia di Zampa, i Racconti romani con la regia di Franciolini, La ciociara con la regia di De Sica, Gli indifferenti con la regia di Maselli.
La produzione moraviana, dal '47 al '59, cioè da La romana ai Nuovi racconti romani (1959) è stata infatti giudicata da certa critica come quella più aderente alla poetica del Neorealismo. "Ma a ben vedere Moravia, se si eccettua il linguaggio neorealistico dei bozzetti di tipo popolare, resta ancora fedele alla sua "indifferenza" di inizio, quale sostanza d'una pena esistenziale nei confronti della crisi sviluppatasi in seno all'umanesimo tradizionale" (Pandini).
La classe dirigente italiana nell’immediato dopoguerra provocò una forte reazione al neorealismo, suscitando atteggiamenti polemici più impegnati sul fronte della neoavanguardia, e Moravia, intravedendo nella polemica l’ipocrisia di una società rimasta conformista, riprese a lavorare nel teatro, nella speranza di avere la possibilità di un colloquio più diretto e di una denunzia più efficiente e costruttiva per il pubblico. Testimonianza di questa crisi sono i suoi numerosi viaggi all'estero e La noia (1960) in cui Moravia recuperava "il suo tema preferito, ricollegabile alle sorti di scacco e d'impotenza della indifferenza d'inizio, con abbondanza di tesi da dimostrare intorno al tema antico della sua atonia morale, che trova nel clima sociale e ideologico degli anni Sessanta una nuova significazione e una sempre maggiore evidenza nel senso di distacco da una realtà inautentica.
L'inizio del nuovo decennio segna anche una svolta nella produzione e nell'impegno culturale di Moravia. Il romanzo, come forma espressiva tradizionale, è messo in crisi dal nascere delle neoavanguardie. Il Gruppo 63, in un convegno tenutosi a Palermo, entra in polemica con Moravia [...] Moravia, molto sensibile a queste pressioni, rivede il suo lavoro e inizia la composizione di un nuovo romanzo, L'attenzione, che si configura come romanzo nel romanzo" (Pandini).
Con Siciliano e Dacia Maraini (intanto si era separato da Elsa Morante) fonda una compagnia teatrale detta del Porcospino. Ma l'opera teatrale di Moravia, pur testimoniando la vivacità e la vitalità di uno scrittore di forte vena, non aggiunge nulla alla sua validità di artista narrativo; testimonia soltanto la minore fiducia del nostro autore nel romanzo, mentre lo fa rivolgere sempre più al saggio-racconto. Il segno della sua insoddisfazione traspare nel romanzo Io e lui (1971).
Tra le altre opere si ricordano i romanzi: La vita ínteriore (197 ; 1934 (1982); L'uomo che guarda 1985); Ritorno a Roma (1989) e, postumo, La donna leopardo; i volumi di racconti: La cosa (1983), La villa del Venerdì e altri racconti (1990). ; 1934 (1982); L'uomo che guarda 1985); Ritorno a Roma (1989) e, postumo, La donna leopardo; i volumi di racconti: La cosa (1983), La villa del Venerdì e altri racconti (1990).
Muore per un malore improvviso a Roma il 26 settembre 1990.
|
| Info: |
Per scaricare devi usare un client come uTorrent o Transmission |
| AnnounceURL
| http://tracker.tntvillage.scambioetico.org:2710/announce |
| Hash | feee98adc629264f941fe2ba59362dfe60657167 |
|
| Peers |
seeds: 28 ,
leech: 2
|
| Size | 3.76 MB |
| Completato | 637x |
| Aggiunto
| 24.05.12 - 11:05:05 |
| Uploader |  torchitorio torchitorio |
| Votazione |
 (Voti: 0) (Voti: 0) |
|
|
|
|

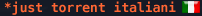

 (Voti: 0)
(Voti: 0)